L’importanza della collocazione nel sistema imperialista
Una delle
questioni più importanti, per chi voglia operare politicamente in un
qualsiasi Paese, è capirne la natura. Uno degli aspetti più importanti a
questo scopo è stabilire quale sia la collocazione del Paese
nell’economia-mondo, per usare un termine caro a Wallerstein. In termini
marxisti, bisogna scendere dall’astrattezza del modo di produzione
capitalistico alla sua concretizzazione, cioè alla formazione
economico-sociale storicamente determinata. Secondo
Wallerstein l’economia-mondo è spazialmente gerarchizzata, essendo
divisa in tre zone: una alta, il centro, una media, la semiperiferia, e
una bassa, la periferia1.
Lenin definiva il capitalismo, giunto alla fase più alta di sviluppo,
come imperialismo. Anche per Lenin l’imperialismo si divide in una
metropoli imperialista, costituita da Stati centrali dominanti e da una
periferia, costituita da Stati subalterni e dipendenti dai primi.
Naturalmente operare politicamente in un Paese centrale o periferico o
semiperiferico è molto diverso, richiedendo un approccio diverso. La
struttura economica e di classe è diversa. Ad esempio, nei Paesi
centrali il capitale è meglio organizzato e i suoi rapporti di
produzione sono più radicati e più forti. In più di un secolo di storia
le rivoluzioni sono avvenute in Paesi periferici e semiperiferici (se
intendiamo la Russia del 1917 come Paese semiperiferico). Si tratta di
un problematica già presente in Gramsci, quando distingue la
“Rivoluzione in Occidente” da quella appena svoltasi in Russia. Fra
l’altro Gramsci fu ispirato direttamente da Lenin che si rendeva conto
delle specificità della rivoluzione nei Paesi avanzati.
La collocazione dell’Italia in una prospettiva storica
Quindi che
tipo di formazione economico sociale è l’Italia e come si colloca nella
gerarchia
spaziale dell’economia mondiale? Negli ultimi anni si è diffuso un giudizio dell’Italia come paese periferico, in riferimento alla posizione occupata nell’area euro. Secondo alcuni l’Italia sarebbe addirittura una semicolonia e la sua classe dominante non una vera classe capitalistica ma una sorta di borghesia “compradora”, cioè una borghesia che fa gli interessi del capitale estero. Il termine di borghesia compradora è tipico dei Paesi periferici dove svolge il ruolo di agente commerciale – comprador – di imprese la cui sede è all’estero. L’uso di termini come periferia, semicolonia e borghesia compradora trovano terreno fertile nelle contraddizioni europee, e sono utilizzati da chi ritiene il nostro Paese e le sua classe dirigente politica ed economica sostanzialmente subalterni e proni agli interessi di altri Paesi.
spaziale dell’economia mondiale? Negli ultimi anni si è diffuso un giudizio dell’Italia come paese periferico, in riferimento alla posizione occupata nell’area euro. Secondo alcuni l’Italia sarebbe addirittura una semicolonia e la sua classe dominante non una vera classe capitalistica ma una sorta di borghesia “compradora”, cioè una borghesia che fa gli interessi del capitale estero. Il termine di borghesia compradora è tipico dei Paesi periferici dove svolge il ruolo di agente commerciale – comprador – di imprese la cui sede è all’estero. L’uso di termini come periferia, semicolonia e borghesia compradora trovano terreno fertile nelle contraddizioni europee, e sono utilizzati da chi ritiene il nostro Paese e le sua classe dirigente politica ed economica sostanzialmente subalterni e proni agli interessi di altri Paesi.
L’uso di
questa terminologia è, però, sbagliato e fuorviante. È senz’altro vero
che la Germania (o l’asse franco-tedesco a seconda delle
interpretazioni), svolge un ruolo egemonico economicamente e, in parte,
anche politicamente nella Ue. Tuttavia,
definire l’Italia una semicolonia e la sua classe dirigente economica
una borghesia “compradora” è una forzatura che nasconde la realtà. La
realtà è che l’Unione europea e l’unione economica e monetaria europea
sono state volute fortemente dalla classe dominante italiana per i
propri interessi e cioè per imporre quelle controriforme capitalistiche
che altrimenti non sarebbero state realizzate. Interessi, quindi, non di
una borghesia intermediaria e commerciale, ma di una borghesia
industriale e finanziaria inserita nel mercato europeo e mondiale con un
ruolo importante dal punto di vista della produzione e delle
esportazioni sia di merci che di capitale.
Questo naturalmente non toglie che all’interno dell’Europa non ci sia
una gerarchia, così come non toglie che ci sia uno scontro in atto tra
le varie frazioni del capitale europeo e gli Stati che le rappresentano.
Ad ogni modo, quando si impiegano delle categorie bisogna evitare facili incasellamenti. L’imperialismo
attuale è intimamente connesso con quello dell’epoca di Lenin ma allo
stesso tempo è diverso, perché non si basa sul controllo territoriale
diretto della metropoli sulla periferia come nel periodo coloniale, ma
su un controllo soprattutto indiretto, economico, politico e tecnologico.
All’inizio del XIX secolo il centro metropolitano produceva prodotti
industriali che andavano alla periferia e quest’ultima produceva
prodotti agricoli e minerari che andavano verso la metropoli. Anche
allora era diffusa l’esportazione di capitale e di attività industriali
dal centro alla periferia, dove, per varie ragioni, il profitto è più
alto. Gli investimenti industriali, però, all’epoca riguardavano
soprattutto la costruzione di ferrovie e il settore minerario. Oggi, le
catene della produzione manifatturiera si estendono globalmente
attraverso i paesi centrali e semiperiferici e talvolta periferici. L’aspetto
dell’uso forza militare rimane fondamentale, ma viene utilizzato in
ultima istanza, spesso nella forma della coalizione imperialista. Dal
punto di vista economico, l’Imperialismo attuale è quello delle
multinazionali, anche se di recente, prima a causa della crisi della
globalizzazione e dello sviluppo del protezionismo e, poi, della crisi
del coronavirus, si assiste a un revival del ruolo dello Stato, come sostegno e difesa del proprio capitale multinazionale.
Ad ogni modo, lo Stato non ha mai abdicato al ruolo di sostegno
all’espansione internazionale del proprio capitale, neanche l’Italia,
sebbene la sua struttura statuale non abbia lo stesso peso e la stessa
capacità di azione, sia diplomatico-politica sia militare, di altri
Stati. Quanto alla posizione occupata dai singoli Paesi
nell’imperialismo o nell’economia-mondo, come preferiamo definirla,
esiste una articolazione di posizioni in tutte e tre le ripartizioni
definite da Wallerstein, a partire dal centro, dove esiste una gerarchia
interna, per quanto soggetta a essere rimessa in discussione. Quindi se
esiste una forma specifica (storica) di imperialismo, esiste anche una
posizione specifica del singolo Paese.
Il capitale e
la borghesia italiani hanno lottato sin dall’Unità per inserirsi
all’interno del centro metropolitano. Malgrado le sue debolezze, povera
di materie prime e inizialmente anche di capitali, e giunta ultima
all’unità nazionale e alla corsa alle colonie, l’Italia è riuscita a
passare dalla semiperiferia al centro imperialista, a costo di gravi
sofferenze per i lavoratori italiani e per le popolazioni coloniali, tra
l’inizio del XX secolo e la seconda guerra mondiale. La sua debolezza
economica e militare, specie se confrontata con la capacità industriale e
militare di Inghilterra, Germania e soprattutto Usa, non toglie che dal
punto di vista qualitativo l’Italia sia stata un Paese imperialista al
pari degli altri. Anzi, la sua appartenenza al centro si è confermata
con l’espansione economica post-bellica degli anni ’60. Già all’inizio
del XX secolo l’Italia presentava una forte concentrazione monopolistica
di capitale industriale al Nord e una tendenza imperialista industriale
verso i Balcani, l’Africa del Nord e il Corno d’Africa2.
I prodotti finiti della manifattura già nel 1913 rappresentavano nelle
esportazioni italiane la quota maggiore (31,8%), che crebbe
ulteriormente durante gli anni ’30 (41,7% nel 1938), mentre la quota di
esportazioni di materie prime greggie e lavorate diminuiva
contestualmente3. La
stessa scelta di partecipazione alla Prima guerra passando dalla
alleanza con la Germania e l’Austria a quella con il Regno Unito e la
Francia, più che alle rivendicazioni sui territori irredenti, fu dovuta
alla volontà di partecipare alla nuova spartizione delle colonie, che
sarebbe seguita alla fine della guerra, e in particolare all’espansione
economica nei Balcani, che prevedeva il controllo dell’Adriatico4.
Il fascismo, fra le altre cose, fu l’espressione della volontà di
entrare definitivamente nel novero delle potenze centrali, sia con
l’impulso allo sviluppo industriale, grazie alla combinazione di Stato e
monopoli privati, sia con la creazione di uno “spazio vitale
mediterraneo” italiano.

Gli indicatori economici per la collocazione dell’Italia nel centro
L’Italia,
semmai, presenta la peculiarità specifica di essere divisa in due
parti, una, il Centro-Nord, che fa parte a tutti gli effetti del centro e
una parte, il Sud che rappresenta una sorta di semiperiferia rispetto
al Nord dell’Italia. Ma,
dal momento che il peso del Centro-nord è preponderante, come Paese nel
suo complesso, l’Italia appartiene al centro del sistema economico
capitalistico. Un
indicatore importante per la collocazione in una delle tre parti del
sistema economico mondiale è, secondo Wallerstein, il Pil pro capite. Il
Pil pro capite a parità di potere d’acquisto dell’Italia è stato nel
2018 di 29.700 euro, cioè molto più vicino al dato di due Paesi centrali
come la Francia (32.100 euro) e il Regno Unito (32.600), che a quello
di Paesi semiperiferici come la Bulgaria (15.700) e la Serbia (12.200).
Se poi osserviamo il Pil pro-capite del Nord Ovest (36.600) e del Nord
Est (35.600) dell’Italia, vediamo che è nettamente superiore a quello
medio di Francia e Regno Unito, mentre quello del Centro Italia è pari a
quello francese. Al contrario il Sud dell’Italia presenta un Pil pro
capite di 19.700 euro, comunque superiore a quello della Bulgaria e
della Serbia, ma molto al di sotto di quello della Francia e del Regno
Unito e ancora più al disotto del Nord Italia5.
È difficile
parlare di Italia come Paese semicoloniale e semiperiferico, visto che,
se andiamo a guardare la bilancia dei conti correnti, cioè lo stato
delle transazioni di merci, servizi, redditi da lavoro e da capitale e
trasferimenti correnti, possiamo osservare che il surplus di conto corrente nei dodici mesi terminanti a marzo 2020, secondo la Banca d’Italia6,
è stato di 57,7 miliardi di euro (il 3,2% del Pil), migliorato
ulteriormente rispetto al corrispondente periodo del 2019, grazie
soprattutto all’aumento dell’avanzo mercantile (da 46 a 62,3 miliardi di
euro). Per un
confronto con altri Stati, considerati appartenenti al centro, vediamo
le statistiche Ocse: nel 2019 il Regno Unito presenta un deficit della
bilancia dei conti correnti del -3,78% sul Pil, la Francia del -0,67% e
la Spagna del -2,0%, viceversa l’Italia registra un surplus del +2,96%.
Solo la Germania, fra i Paesi maggiori dell’Europa, fa meglio
dell’Italia con +7,13%7.
L’imperialismo
non è una politica, ma uno stadio di sviluppo del capitalismo, che può
quindi esprimersi in modo apertamente violento o usare mezzi pacifici, a
seconda dei casi. Questo stadio di sviluppo si distingue, secondo
Lenin, per alcune caratteristiche economico-strutturali: la
concentrazione e centralizzazione dei mezzi di produzione e del
capitale, la fusione del capitale bancario con quello industriale e il
formarsi sulla base dell’unione di questo capitale finanziario di una
oligarchia finanziaria, l’importanza dell’esportazione di capitale in
confronto a quelle di merci, il sorgere di associazioni internazionali
di capitalisti che si ripartiscono il mondo e la compiuta ripartizione
della terra tra le maggiori potenze capitalistiche8.
Ci
concentreremo, riguardo all’Italia, sulla concentrazione della
produzione, sull’integrazione di industria e finanza, e
sull’esportazione di capitale. Nell’insieme
dell’economia tra 2001 e 2018 le imprese oltre i 500 addetti, pur
essendo appena lo 0,1% del totale, sono passate dal 21,2% degli addetti
al 22,8%9. Ci
sono, inoltre, due considerazioni da fare. La prima è che nell’insieme
delle imprese ci sono settori che non sono tipicamente parte della
produzione capitalistica e sono caratterizzati da piccole dimensioni,
come il piccolo commercio e l’artigianato, che in Italia resistono negli
interstizi della società capitalistica meglio che altrove. La seconda è
che, come è tipico del modello italiano di struttura imprenditoriale,
le micro, piccole e medie imprese spesso sono parte di gruppi o comunque
subalterne e fornitrici monocliente di imprese più grandi. Il
5% delle imprese è organizzato in strutture di gruppo che occupano un
terzo degli addetti complessivi (5,6 milioni di dipendenti)10.
Inoltre, tra tutte le imprese del censimento permanente dell’Istat il
32,5% ha rapporti di commessa e il 25,4% ha un rapporti di subfornitura
con altre imprese, dati che nella manifattura salgono rispettivamente al
46,1% e al 39%11. Per
avere una idea più chiara sul processo di concentrazione osserviamo il
settore della manifattura, dove, nel periodo della crisi, tra 2008 e
2017, si è svolto un processo di forte concentrazione. Le
imprese più grandi, al di sopra dei 250 addetti, pur essendo lo 0,3%
del totale, passano dal 32,6% al 39,7% del valore aggiunto complessivo e
dal 26,8% al 30,7% dei dipendenti complessivi12.
La
concentrazione è particolarmente intensa nel settore bancario e
assicurativo. Nel settore bancario ci sono due grandi semimonopolisti,
Unicredit e Banca Intesa, la quale proprio in questo periodo sta
portando avanti un progetto di acquisizione della quarta banca italiana,
Ubi, operazione che creerebbe un notevole monopolista. Il settore
assicurativo vede il mercato dominato da tre compagnie: le Assicurazione
generali, uno degli maggiori gruppi d’Europa e vera cassaforte del
capitalismo italiano, Allianz, e Unipol. Anche
l’aspetto della integrazione tra capitale industriale e finanziario
(bancario e assicurativo), che per Lenin è uno dei presupposti
strutturali dell’imperialismo, è molto presente in Italia ed collegato
alla concentrazione del potere economico italiano nelle mani di pochi
gruppi e famiglie industriali.
Mediobanca, la principale banca d’affari italiana, anche se non è più
così centrale nel capitalismo italiano come all’epoca di Cuccia,
continua a svolgere un ruolo importante, perché vi partecipano alcune
tra le famiglie di industriali più importanti in Italia (Berlusconi,
Benetton, Gavio, Doris, Della Valle), riunite in un accordo di
consultazione, e perché possiede il 13% delle Generali, nel cui capitale
sono presenti altre importanti famiglie italiane di industriali
(Caltagirone, Benetton e De Agostini). Un esempio di integrazione tra
capitale industriale e finanziario è Del Vecchio, patron di Luxottica,
che è il primo azionista di Mediobanca con il 9% delle azioni, ed è
presente anche in Generali (4,5%) e Unicredit (2%). Recentemente, Del
Vecchio ha chiesto l’autorizzazione alla Bce per salire al 20% di
Mediobanca, il che, attraverso la partecipazione in Generali, lo
porterebbe a rafforzare la sua capacità di controllo della finanza
italiana e a costruire un polo finanziario italiano con al centro
Mediobanca e le Generali.
Negli ultimi anni abbiamo avuto vari esempi di centralizzazioni proprietarie, mediante acquisizioni/fusioni cross border
(cioè internazionali), portate avanti da grandi imprese italiane, come
Fiat, prima con Chrysler e ora con Psa, e Luxottica con Essilor, solo
per citare quelle più famose. Nei
primi tre mesi del 2020 le multinazionali italiane hanno finalizzato
operazioni di fusione o acquisizione all’estero per 6,6 miliardi di euro
(2,9 miliardi nello stesso periodo del 2019), mentre le operazioni
dall’estero sono ammontate a soli 1,2 miliardi (2,4 nel 2019)13.
Dunque, siamo arrivati a uno degli aspetti più importanti, per la
collocazione “spaziale” dell’Italia, che è la crescita dell’esportazione
di capitale all’estero. A questo proposito prendiamo in considerazione
gli investimenti diretti all’estero (Ide) in uscita dall’Italia verso il
resto del mondo14.
Fig. 1 – Crescita dello stock degli ide dell’Italia verso l’estero (1980-2018; Ide in % sul Pil e in milioni di dollari)
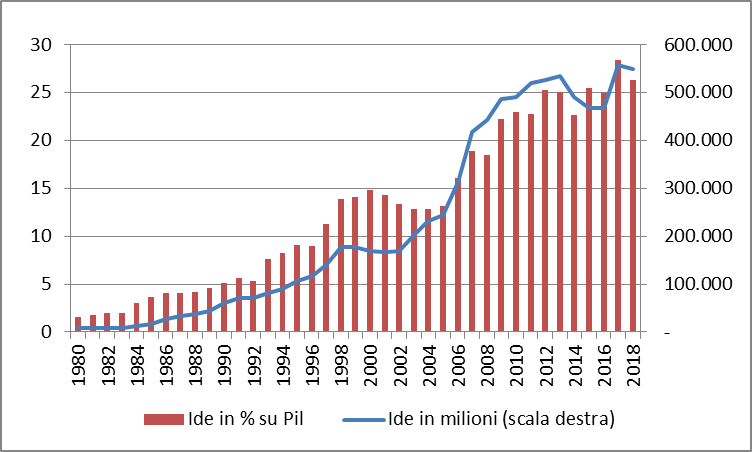
Fonte: nostra elaborazione su dati Unctad
Lo stock
degli Ide in uscita, tra 1980 e 2018, è cresciuto notevolmente, passando
dall’1,5% al 26,3% sul Pil. L’Italia è esportatrice netta di capitale,
in quanto gli Ide in uscita superano quelli in entrata, già dagli anni
’80 e stabilmente dagli anni ’90, nel 2018 lo stock degli Ide in uscita
ha superato quello degli Ide in entrata di circa 118 miliardi di dollari.
Malgrado l’Italia presenti uno stock di Ide inferiore (548 miliardi di
dollari) a quelli di Francia (1.466 miliardi) e Germania (1.645
miliardi)15, la
sua crescita media annua è stata maggiore nel periodo tra 1980 e 2018,
raggiungendo il +12,03%, contro il +10,06% della Germania e il +11,4%
della Francia. Nello
stesso periodo lo stock di Ide italiani è passato dal 17% e 29,4% di
quelli della Germania e della Francia a rispettivamente il 33,4% e
36,4%. C’è da notare che la crescita degli Ide italiani si è
intensificata prima durante gli anni ’90, e poi subito dopo la crisi del
2007-2008, con un breve rallentamento tra 2014 e 2016 e un rialzo nel
2017 e 2018 (Fig.1). In
entrambi i casi la crescita degli investimenti all’estero ha seguito
una forte crisi economica (all’inizio degli anni ’90 e poi nel
2007-2008), e il calo del profitto nell’economia interna. Alla
stagnazione nell’economia interna fa da contraltare l’aumento
dell’attività dei capitali a livello internazionale, coerentemente con
la teoria marxista che lega l’esportazione di capitale alla
sovraccumulazione di capitale e quindi alla necessità di contrastare la
caduta del saggio di profitto, investendo
dove i profitti sono più alti o perché i salari e altri tipi di costi
sono più bassi o perché il mercato è più ricco e consente margini più
alti grazie a prezzi più alti.
La dinamica illustrata nella Fig.2 è quella tipica di un Paese a
capitalismo avanzato, con una tendenza all’aumento della composizione
organica (il rapporto tra capitale investito in mezzi di produzione e
capitale investito in salari) e una corrispondente caduta del saggio di
profitto16.
Fig. 2 – Andamento del saggio di profitto e della composizione organica di capitale in Italia (1970-2016; 1970=100)

Fonte: nostra elaborazione su dati Onu-National Account
Le
multinazionali italiane negli ultimi anni, tra 2010 e 2017, sono passate
da 22.081 a 23.727 con una crescita media annua di quasi l’1%. Il loro
fatturato è salito da 434,6 miliardi di euro a 538,3 miliardi (+2,7%
medio annuo), mentre gli occupati sono saliti da 1.605.146 a 1.794.501 (+1,4%)17.
Malgrado le multinazionali a controllo italiano siano solo lo 0,5%
delle imprese residenti in Italia, i loro addetti e il loro fatturato
all’estero rappresentano rispettivamente il 10,9% e il 17% del totale
italiano. I Paesi dove la presenza è maggiore in termini di addetti sono
nell’ordine: gli Stati Uniti (286mila addetti), il Brasile (146mila),
la Cina (140mila), la Romania (125mila), la Germania (107mila), e la
Francia (75mila). Per quanto riguarda il fatturato al primo posto sono
gli Stati Uniti (25,4% del totale), seguiti dalla Germania (11,7%)18. Alcuni
pensano all’Italia come colonia delle imprese della Germania. In
realtà, anche la presenza dell’Italia in Germania è massiccia,
sicuramente con valori assoluti inferiori a quelli della presenza
tedesca nel nostro Paese, ma che rispecchiano, grosso modo, le
differenti dimensioni delle due economie, dal momento che il Pil della
Germania è di un terzo più grande di quello italiano.
Nel 2017 la Germania era presente in Italia con 1.016 imprese che
impiegavano 156mila addetti e sviluppavano 87,1 miliardi di fatturato.
L’Italia, invece, era presente in Germania con 1.671 imprese che
impiegavano circa 107mila addetti e fatturavano 63 miliardi di euro. Non
certo numeri da colonia19.
Conclusioni
Contrariamente
a una opinione diffusa in certi settori politici e culturali, l’Italia è
tutt’altro che un paese periferico, semiperiferico o semicoloniale.
L’Italia appartiene al centro metropolitano all’interno del sistema
imperialista. Gli
indicatori che abbiamo visto, pur in modo rapido e parziale – il Pil pro
capite, la bilancia dei conti correnti, gli Ide e la presenza delle
multinazionali a controllo italiano all’estero – lo provano. Tuttavia,
la formazione economico-sociale italiana presenta delle specificità e
delle peculiarità importanti che possono aiutarci a definire con più
precisione il suo posizionamento.
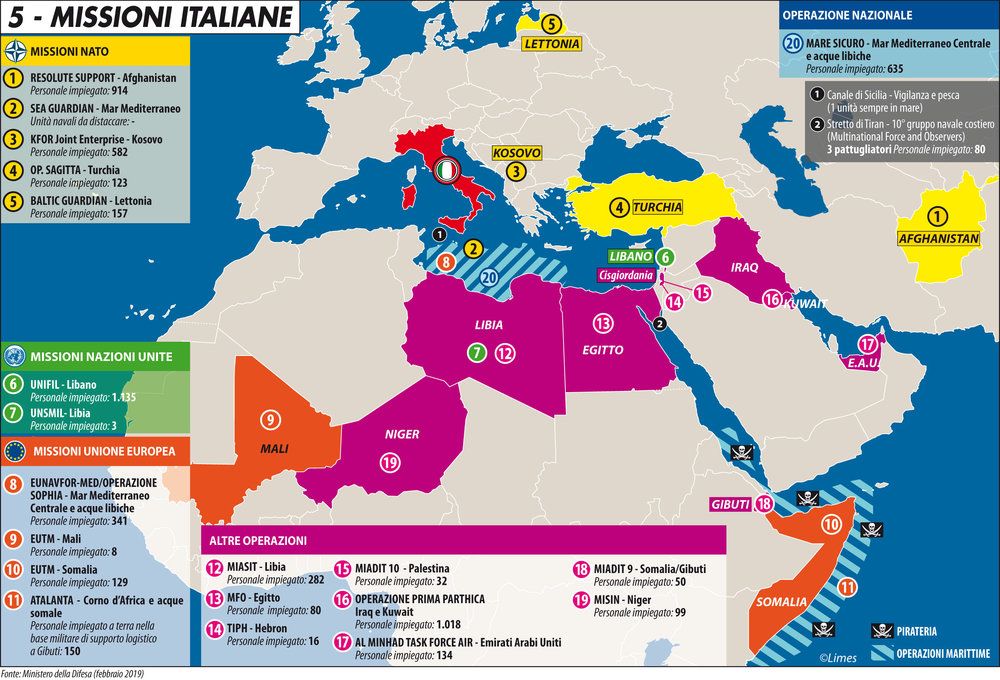
fonte: Limesonline.com
Le
caratteristiche dei Paesi centrali e imperialisti sono sì presenti nella
formazione economico-sociale italiana, ma in misura meno accentuata che
in altri Paesi come la Germania e la Francia. La struttura economica
dell’Italia si caratterizza per una notevole concentrazione del capitale
in pochi grandi gruppi privati e semi-pubblici, anche se presenta un
numero di micro-imprese e Pmi molto maggiore di quello di altri Paesi
centrali. L’esportazione di capitale è cresciuta molto rapidamente ma in
valore assoluto rimane significativamente inferiore a quella di altri
Paesi centrali di dimensioni comparabili. Soprattutto
ci sono due altre peculiarità di cui tenere conto. La prima è che
l’Italia contiene al suo interno il Mezzogiorno, una zona semiperiferica
o, per dirla con Arrighi, una sorta di “terra di nessuno” tra
semiperiferia e centro, anche se Arrighi riferiva questo tipo di
classificazione all’intera Italia20.
La seconda è che lo Stato italiano presenta delle debolezze, sia sul
piano diplomatico-politico sia sul piano militare, che non lo rendono
completamente adeguato alle necessità di espansione del capitale
italiano. Espansione economica e capacità di proiezione di forza
politico-militare sono un binomio inscindibile anche oggi.
La grande borghesia italiana è tutt’altro che una borghesia compradora
ed è conscia dei limiti che la Ue impone all’Italia, ma è conscia anche
dei limiti dello Stato italiano e ritiene di poter essere meglio
tutelata in un ambito più vasto, sia questo la Ue e la Uem o la Nato.
Del resto, non può essere altrimenti per un Paese che ha perso l’ultima
guerra ed è disseminato di basi militari statunitensi. L’europeismo e
l’atlantismo del grande capitale italiano nascono da questa situazione,
non da altro. Un esempio della scarsa capacità dello Stato italiano di
difendere gli interessi all’estero del suo capitale si è avuto con la
guerra contro la Libia di Gheddafi, cui la Francia ha dato avvio proprio
per soppiantare l’Italia, e in particolare l’Eni, in quel Paese. Del
resto, il confronto imperialista tra Italia e Francia nel Nord Africa è
vecchissimo e data dall’occupazione francese della Tunisia nel 1881,
fatto che in Italia venne definito lo “schiaffo di Tunisi”, ed è
continuato fino ad oggi, passando per il colpo di Stato in Tunisia
appoggiato dall’Italia nel 1987 contro Bourghiba, che portò al potere
Ben Alì, e alla sostituzione dell’influenza francese con quella
italiana.
Come fece
notare già Lenin il capitalismo è caratterizzato da uno sviluppo
diseguale, che tende a modificare i rapporti di forza tra frazioni di
capitale e tra gli Stati che ne sono espressione. Quindi, nulla è
acquisito per sempre e le varie frazioni di capitale del centro e i loro
Stati sono continuamente in lotta per mantenere o migliorare le proprie
posizioni. Il capitale e lo Stato italiani non fanno eccezione. Oggi
sono collocati, anche se nelle posizioni gerarchiche più basse,
all’interno del centro imperialista, ma lottano in continuazione per
mantenere e migliorare le proprie posizioni. In questa lotta rientra il revival
della presenza dello Stato nell’economia, con le ricapitalizzazioni
delle imprese ad opera della Cdp, i prestiti garantiti dallo Stato a
multinazionali come Fca, e l’ampliamento del golden power,
cioè la capacità in capo allo Stato di impedire acquisizioni di imprese
strategiche dall’estero. E vi rientra anche il riarmo in atto da anni,
che ha portato all’aumento della capacità militare di “proiezione di
forza” – soprattutto con il rafforzamento della componente aeronavale – e
alla partecipazione a numerose missioni militari all’estero, che spesso
si sono tradotte in azioni di guerra, come in Somalia, Afghanistan,
Iraq e Libia. Tutte
queste operazioni sono state svolte per poter pesare di più a livello
internazionale e per garantire la partecipazione del capitale italiano
alla spartizione delle risorse di quei Paesi. Ad esempio, la presenza
italiana in Iraq tra 2003 e 2006 era legata alla possibilità dell’Eni di
rientrare nella spartizione del petrolio e in particolare a contratti
preesistenti per dei pozzi nei pressi di Nassiriya, dove in effetti era
dislocato il contingente italiano. Dal 2014 un nuovo contingente
italiano è presente in Iraq, di cui una parte è stato destinato a
difendere una diga nei pressi di Mosul per la quale la ditta italiana
Trevi aveva vinto un contratto di manutenzione. Bisogna,
infine, ricordare che un imperialismo o uno Stato imperialista “debole”
è debole solo in termini relativi, cioè rispetto a un altro
imperialismo. Soprattutto debole non vuol dire inoffensivo né tanto meno
pacifico. Sono proprio gli imperialismi “deboli”, desiderosi di
migliorare la propria posizione, o in decadenza a essere spinti a una
maggiore aggressività sia all’interno, verso i propri lavoratori, sia
all’estero, verso altri Paesi.
Note
1 Immanuel Wallerstein, La crisi come transizione, in AA. VV. “Dinamiche della crisi mondiale”, Editori Riuniti, Roma 1988.
2 Richard Webster, L’imperialismo industriale italiano tra 1908 e 1915, Einaudi, 1997.
3 Domenico Moro, L’internazionalizzazione dell’economia dell’Italia nel suo passaggio dalla semiperiferia al centro dell’economia-mondo, “Dialettica e Filosofia”, 26 febbraio 2018.
4 Gian Enrico Rusconi, L’azzardo del 1915. Come l’Italia decide la sua guerra, Il Mulino, Bologna 2009.
5 Eurostat, Regional economic accounts, Gross domestic product (GDP) at current market prices by NUTS 2 regions (nama_10r_2gdp).
6 Banca d’Italia, Statistiche, Bilancia dei pagamenti e posizione patrimoniale sull’estero, 20 maggio 2020. https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/bilancia-pagamenti/2020-bilancia-pagamenti/statistiche_BDP_20200520.pdf
7 Oecd.Stat, Balance of payments BMP6, current account balance as a % of GDP.


Nessun commento:
Posta un commento