da contropiano
Almirante? Un servo dei nazisti
Come Almirante collaborava con i nazisti.
L’Osservatorio
: … quando l’uso della memoria è finalizzato alla riscrittura della
Storia. E’ il caso di Ladispoli dove il trentaseienne Alessandro Grando,
eletto sindaco con i voti di una coalizione fortemente connotata a
destra, ha deciso con il beneplacito del Prefetto di Roma di intitolare a
Giorgio Almirante la piazza antistante la parrocchia del Sacro Cuore.
Come riportato nell’intervista a Emanuele Rossi de Il Messaggero lo
scorso 16 marzo, la figlia di Almirante Giuliana De’ Medici ha
ringraziato il parroco: «Benedirà la piazza e speriamo dica ai giovani
chi era mio padre».
Questo
perché nei giorni scorsi il sacerdote aveva detto che per lui quella
«si chiamava piazza della Chiesa e non piazza Almirante».
Cominciamo
noi a ricordare chi era Almirante riportando la storia dell’assoluzione
dall’accusa di falso giunta dopo lunghe vicissitudini giudiziarie al
quotidiano “L’Unità” per aver titolato il giornale del 27 giugno 1971
: “Un servo dei nazisti. Come Almirante collaborava con gli occupanti tedeschi ”
da
Archivio la Repubblica.it;
Almirante e gli scheletri di Salò
In Maremma lo chiamavano il “manifesto della morte”. Era il maggio del 1944, apparve una mattina di primavera sui muri dell’ alta Toscana, tra le pendici dell’ Amiata e la Val di Cecina, nei paesi sopra Grosseto già occupati dalle insegne di Hitler. Vi era riprodotto l’ ultimatum rivolto il 18 aprile da Mussolini ai militari “sbandati” dopo l’ 8 settembre 1943
e ai ribelli saliti in montagna: consegnatevi ai tedeschi o ai fascisti entro trenta giorni, oppure vi aspetta la fucilazione. Morte era minacciata anche a chi avesse dato aiuto o riparo ai partigiani.
In Maremma lo chiamavano il “manifesto della morte”. Era il maggio del 1944, apparve una mattina di primavera sui muri dell’ alta Toscana, tra le pendici dell’ Amiata e la Val di Cecina, nei paesi sopra Grosseto già occupati dalle insegne di Hitler. Vi era riprodotto l’ ultimatum rivolto il 18 aprile da Mussolini ai militari “sbandati” dopo l’ 8 settembre 1943
e ai ribelli saliti in montagna: consegnatevi ai tedeschi o ai fascisti entro trenta giorni, oppure vi aspetta la fucilazione. Morte era minacciata anche a chi avesse dato aiuto o riparo ai partigiani.
Fu
il sigillo, quel decreto legge voluto dal duce di concerto con Rodolfo
Graziani, per un’ indiscriminata caccia all’ uomo e per rastrellamenti
feroci, in una terra insanguinata dalle stragi. Solo in Maremma, tra il
13 e il 14 giugno, furono ammazzati a Niccioleta ottantatré minatori.
 Ma
il manifesto che quel tragico ultimatum sunteggiava non era firmato da
un comando militare della Rsi o da un presidio delle SS. Era firmato da
Giorgio Almirante, allora capo di gabinetto di Fernando Mezzasoma,
ministro della Cultura Popolare che curava la Propaganda della
Repubblica Sociale. Una figura non di seconda fila – quella del
trentenne Almirante – approdata al governo filonazista di Salò dopo una
robusta esperienza giornalistica da caporedattore nel quotidiano Il
Tevere e da segretario di redazione della Difesa della Razza, la rivista
ufficiale dell’ antisemitismo sulla quale scrisse articoli intonati al
più convinto “razzismo biologico”.
Ma
il manifesto che quel tragico ultimatum sunteggiava non era firmato da
un comando militare della Rsi o da un presidio delle SS. Era firmato da
Giorgio Almirante, allora capo di gabinetto di Fernando Mezzasoma,
ministro della Cultura Popolare che curava la Propaganda della
Repubblica Sociale. Una figura non di seconda fila – quella del
trentenne Almirante – approdata al governo filonazista di Salò dopo una
robusta esperienza giornalistica da caporedattore nel quotidiano Il
Tevere e da segretario di redazione della Difesa della Razza, la rivista
ufficiale dell’ antisemitismo sulla quale scrisse articoli intonati al
più convinto “razzismo biologico”.
È
lo stesso Almirante al quale oggi il sindaco Gianni Alemanno vuole
dedicare una strada di Roma. Se la vicenda del manifesto è stata
sfiorata appena dalle cronache di questi giorni, meno conosciuta è la
storia del processo che proprio sul clamoroso episodio vide negli anni
Settanta il leader della Fiamma inizialmente nelle vesti dell’
accusatore-querelante, poi arretrato nel ruolo di “imputato morale”. Una
vicenda giudiziaria lunga sette anni, dall’ andamento lento, che si
concluse con assoluzione piena per l’ Unità, il quotidiano querelato per
aver pubblicato un documento giudicato da Almirante “vergognosamente
falso” e “calunnioso”.
Per
il fondatore del partito neofascista italiano fu una sconfitta
irrevocabile. La possiamo ricostruire oggi grazie alla documentata
ricerca realizzata nel corso di anni da uno dei testimoni, Carlo
Ricchini – giornalista di lunga esperienza, allora direttore
responsabile del quotidiano comunista, inventore delle prime iniziative
editoriali dell’ Unità – per un libro che deve essere ancora pubblicato
(Il manifesto della morte con la firma di Almirante).
La
sentenza avversa al leader missino era scontata fin dalle prime
udienze, ma un complicato intreccio politico-giudiziario ne rallentò il
cammino. Quel che nelle intenzioni dei promotori doveva essere il
battesimo pubblico dell’Almirante in doppio petto, utilizzato in
alleanze dirette e indirette con la Dc, da liturgia assolutoria si
trasformò, grazie a un’ imbarazzante documentazione, in spinoso teatro
d’ accusa. Da qui le pratiche dilatorie, le ritirate strategiche, le
eccezioni procedurali mosse dagli avvocati di Almirante, che trascineranno il dibattimento per tutti gli anni Settanta, fino all’epilogo sancito soltanto nel 1978.
Il
manifesto di Almirante venne alla luce nell’estate del 1971, scovato da
alcuni storici dell’università pisana negli archivi di Massa Marittima.
L’Unità lo pubblica il 27 giugno sotto il titolo Un servo dei nazisti.
Come Almirante collaborava con gli occupanti tedeschi.
D’intonazione analoga Il Manifesto,
che lo propone con un severo commento di Luigi Pintor. «Ci apparve
subito evidente», racconta Ricchini, «che era stata scoperta una prova
della partecipazione diretta di Almirante alla repressione
antipartigiana, da lui tenuta nascosta, come se il posto occupato a Salò
fosse stato un impiego come un altro e la sua divisa da brigatista nero
un obbligo dovuto alle circostanze».
Intanto
il manifesto firmato Almirante, quasi sempre con la soprascritta
“Fucilatore di partigiani”, riempie i muri d’Italia. Da Reggio Emilia a
Catanzaro, da Terni a Trapani, da Modena ad Avellino, le associazioni
partigiane si mobilitano per denunciare il segretario del Movimento
Sociale. Almirante replica con una pioggia di querele, uscendone ovunque
sconfitto. Ma non a Roma, dove il processo più importante, quello
intentato contro i due quotidiani di sinistra, mostra un percorso
alquanto accidentato.
Fin
da principio Almirante nega tutto. Nega l’autenticità del manifesto,
sostenendo che sia un falso stampato ad arte contro di lui. Nega di
essere stato già allora capo di gabinetto di Mezzasoma (sposta in avanti
la data). Nega che il ministero della Cultura popolare potesse dare
esecuzione al bando di Mussolini. Nega che i ministri di Salò potessero
prendere simili iniziative in territori controllati dalle forze armate
germaniche.
Anche
la prosa illetterata del documento gli risulta estranea, “non ho mai
firmato manifesti o comunicati di tal genere in quel periodo, né
rientrava nelle mie attribuzioni firmare manifesti a nome del ministro”.
Insomma, s’è trattato “d’una vergognosa campagna di stampa”, il titolo
di fucilatore “un’ignobile infamia”. La prima udienza si svolge sul
finire del 1971. Sono chiamati a difendersi dall’accusa di “falso e
diffamazione” i giornalisti Carlo Ricchini e Luciana Castellina, allora
direttore responsabile del Manifesto.
In
realtà non è difficile dimostrare l’autenticità del documento: la copia
fotostatica è autenticata da un notaio che attesta la conformità con
l’originale. «Le prove di oggi sarebbero già sufficienti», dichiara il
pubblico ministero Vittorio Occorsio, autorevole magistrato già
impegnato in quegli anni contro il terrorismo nero. Propone sia chiamato
a deporre il sindaco di Massa Marittima invitandolo a esibire
l’originale del manifesto. La nuova udienza è fissata per il 25 gennaio
del 1972, la conclusione appare prossima.
All’appuntamento
di gennaio si presenta anche l’ onorevole Almirante: sorridente,
impeccabile nel vestito fumo di Londra, cravatta blu con piccoli
cerchietti bianchi. Al principio della deposizione chiama in causa il
Parlamento e le istituzioni che, nonostante il suo passato, hanno
legittimato l’elezione a deputato. «Faccio presente che sono deputato
in Parlamento dal 18 aprile del 1948», esordisce con toni rassicuranti.
«Allora, oltre le regole costituzionali, vi erano norme eccezionali che
vietavano di entrare in Parlamento a coloro i quali avessero assunto
cariche o ricoperto determinate responsabilità nella Rsi. Personalmente
non ho mai subito alcun procedimento penale né fruito di amnistie. Se
c’era qualcosa da dire, quella era l’epoca più adatta, per freschezza di
ricordi, vivacità di polemiche, presenza di testimoni».
In
altre parole, se non sono state fatte rispettare la Costituzione e le
leggi, la colpa non è mia. E il confino di polizia al quale Almirante fu
condannato nel 1947? Un legale gli ricorda il grave provvedimento
subìto per il collaborazionismo con i tedeschi e per le attività
successive alla guerra. Ma il segretario missino ha ricordi confusi. Gli
interessa soltanto rimarcare la totale estraneità al manifesto
pubblicato sui giornali e al bando di morte pronunciato da Mussolini e
Graziani.
«Curare
la diffusione del comunicato o meglio del bando Graziani rientrava
nelle competenze del ministero dell’Interno o di quello delle forze
armate», ribadisce con piglio determinato. Lui boia o assassino di
partigiani? Ma non scherziamo. A nulla sembrano valere le nuove prove
documentali portate dal sindaco di Massa, un operaio di taglia robusta
dal buffo nome di Rizzago Radi che sfila dalla cartellina l’ originale
del documento firmato da Almirante, insieme alla lettera della
Prefettura che accompagna l’invio dei manifesti e la missiva del
vicecommissario prefettizio che rassicura sull’ affissione.
Il
manifesto, dunque, non è un falso. Il processo potrebbe rapidamente
chiudersi, come incoraggia Occorsio. Ma l’assoluzione dei giornalisti
implica la colpevolezza di Almirante. I suoi avvocati sono costretti a
cambiare strategia. L’unico modo per ritardare la sentenza è accorpare
il processo romano ai tanti processi in corso nella penisola in seguito
alle querele di Almirante. Il tribunale, presieduto da Carlo Testi,
sembra acconsentire alla proposta. L’udienza è aggiornata.
La
prima sorpresa, nel prosieguo del dibattimento, è la sostituzione del
pubblico ministero Occorsio con Niccolò Amato, futuro direttore degli
istituti di pena. Il suo orientamento appare capovolto rispetto alle
convinzioni del predecessore, facendo proprie le tesi difensive di
Almirante. Il processo slitta, si arriva a un nuovo rinvio per l’aprile.
Alberto Malagugini, difensore dell’Unità e futuro magistrato della
Corte Costituzionale, non ha dubbi: «Pur di prendere tempo sono state
poste le più strabilianti eccezioni procedurali. Non appena sono apparse
chiare le responsabilità del querelante per l’infame comunicato del
1944, non appena il tribunale è stato posto in condizione di decidere e
il pubblico ministero di udienza l’ha fatto intendere, la difesa ha
cominciato la sua manovra di sganciamento».
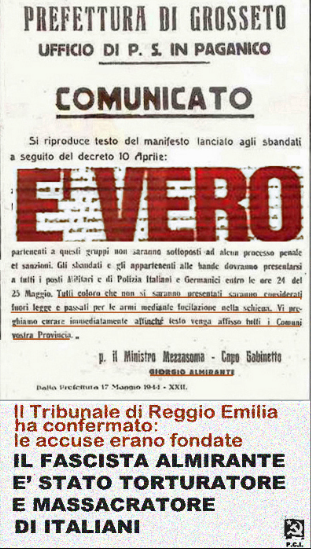 Intanto
in tutta Italia i processi intentati da Almirante si vanno chiudendo
con l’ assoluzione dei querelati. Per tutti gli altri collegi giudicanti
Almirante è un fucilatore di partigiani, a Roma devono ancora
certificarlo. Eppure i supporti documentali sono ovunque gli stessi.
Passano ancora due anni. Nel giugno del 1974, dopo accurate ricerche,
viene prodotta in aula la “prova delle prove”: un telegramma dell’ 8
maggio 1944, spedito dal ministero della Cultura Popolare all’indirizzo
della prefettura di Lucca. È stato trovato negli archivi di Stato, è
firmato Giorgio Almirante, e corrisponde parola per parola al manifesto
conservato a Massa Marittima.
Intanto
in tutta Italia i processi intentati da Almirante si vanno chiudendo
con l’ assoluzione dei querelati. Per tutti gli altri collegi giudicanti
Almirante è un fucilatore di partigiani, a Roma devono ancora
certificarlo. Eppure i supporti documentali sono ovunque gli stessi.
Passano ancora due anni. Nel giugno del 1974, dopo accurate ricerche,
viene prodotta in aula la “prova delle prove”: un telegramma dell’ 8
maggio 1944, spedito dal ministero della Cultura Popolare all’indirizzo
della prefettura di Lucca. È stato trovato negli archivi di Stato, è
firmato Giorgio Almirante, e corrisponde parola per parola al manifesto
conservato a Massa Marittima.
Un
foglietto giallo, tipico dei messaggi telegrafici di quel periodo, con
il decreto di morte pronunciato nell’aprile da Mussolini. Il capo di
gabinetto ne sollecita l’affissione in tutti i comuni della provincia.
Il funzionario che nel maggio del 1944 ha mandato il telegramma nella
tipografia Vieri di Grosseto per la stampa del manifesto s’è dimenticato
di levare la firma di Almirante. Una distrazione che inchioda il leader
del Movimento Sociale alle sue pesanti responsabilità.
Dagli
archivi affiorano anche altre carte compromettenti. Una circolare del
24 maggio 1944, firmata sempre dal capo di gabinetto di Mezzasoma,
ordina ai capi delle province di divulgare non solo i manifesti che
provengono dal ministero della Cultura Popolare ma anche dalle autorità
tedesche. Almirante è sbugiardato su tutti i fronti: è lui che cura la
propaganda del bando Graziani, ed è sempre lui che segue sollecito l’
affissione dei comunicati del Fuhrer. La sua difesa annaspa.
Vittorio
Occorsio, tornato a ricoprire la pubblica accusa, chiede ironico:
«Volete sostenere che è falso anche questo documento, che ci viene
inviato da un ufficio statale e su richiesta del tribunale?». Il
processo è sufficientemente istruito, non resta che chiuderlo. «Dopo la
sentenza», annuncia severo il pubblico ministero, «chiederò che gli atti
siano restituiti alla pubblica accusa per procedere per i reati di
calunnia e falsa testimonianza nei confronti di Almirante. Calunnia per
aver affermato che il manifesto era apocrifo, falsa testimonianza per
tutte le menzogne dichiarate davanti ai giudici».
Bisogna
aspettare ancora altri quattro anni per assistere alla “condanna
morale” del fondatore del Movimento Sociale. Un primo pronunciamento
assolutorio non soddisfa a pieno il quotidiano fondato da Antonio
Gramsci, mentre il Manifesto preferisce fermarsi al traguardo. Solo l’8
maggio del 1978, dopo un intervento della Cassazione, arriva una
sentenza priva d’ ombre, che assolve l’Unità «per avere dimostrato la
verità dei fatti» e condanna Almirante alle spese processuali, anche al
risarcimento dei danni.
«Ma
l’Unità non ha mai chiesto i danni», ricorda Ricchini in chiusura del
suo prezioso memoriale. L’unico che non poté leggere la sentenza fu il
pubblico ministero che Occorsio era rimasto vittima di un agguato, per
mano di terroristi ne con passione civile e rigore più l’aveva
sostenuta. Due anni prima Vittorio Due anni prima Vittorio Occorsio era
rimasto vittima di un agguato, per mano di terroristi neri.
SIMONETTA FIORI
SIMONETTA FIORI

Nessun commento:
Posta un commento